




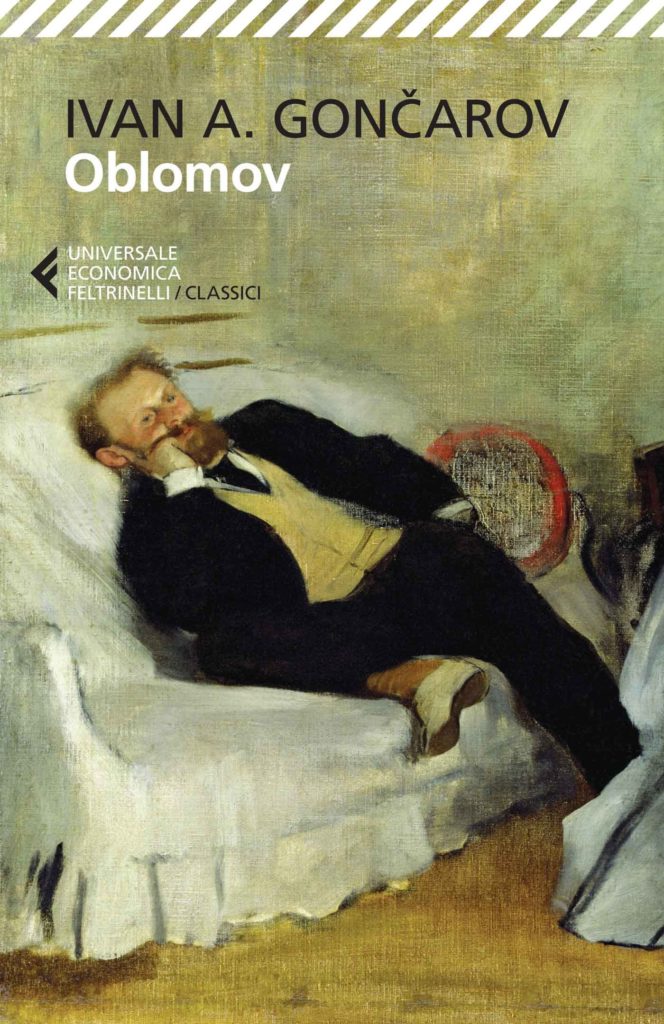
Come si può pretendere di recensire nello spazio di una pagina un romanzo come Oblòmov, pubblicato nel 1859 (ma la cui genesi era durata almeno dieci anni), di Ivan Aleksàndrovič Gončaròv (Simbirsk, 18 giugno1812–San Pietroburgo, 27 settembre1891)? Non posso farlo, infatti, e nemmeno lo voglio. Quello che invece vorrei, attraverso alcune considerazioni personali che seguono una colpevolmente tardiva lettura, è incitare, spingere e forse – se fosse possibile – persino costringere chi non lo abbia ancora fatto a leggere questo romanzo: un indimenticabile e fondamentale romanzo russo, magicamente sospeso tra simbolismo e realismo, che è forse il grande romanzo quasi dimenticato della letteratura russa dell’Ottocento. Un romanzo che possiede tutta l’indubbia forza di un grande classico perché – per ricordare la definizione di Calvino – ancora oggi, dopo 150 anni, ha la capacità di parlare anche di noi, del nostro presente e della nostra condizione umana, con parole che certo, almeno una volta, hanno attraversato la mente e l’anima di ciascuno. Ma naturalmente Oblòmov è un uomo del suo tempo: un piccolo aristocratico russo che campa, o spera di campare, con i suoi servitori di città e i suoi piccoli lussi – sulle spalle di trecentocinquanta miseri contadini, ancora veri servi della gleba, costretti al duro lavoro della terra nella sperduta contrada di Oblòmovka, di sua proprietà. In questo, in fondo, niente di nuovo: abbiamo imparato dai libri di storia del liceo quale fosse la condizione dei contadini russi dell’epoca, e in fondo qui simbolicamente è la condizione stessa della Russia, e della piccola e grande aristocrazia che la governa, a non poter cambiare: è la servitù della gleba stessa, si potrebbe quasi dire, che con la sua esistenza come istituzione inamovibile, toglie l’energia a una intera classe nobile, sostentandola senza bisogno che essa faccia nulla, e prevenendo addirittura i suoi bisogni. Ma ciò che fa di Il’jà Il’ič Oblòmov un caso del tutto speciale è il fatto è che, nel momento in cui lo incontriamo, vale a dire a poco più di trentadue anni di età, egli viva ormai da più di dodici anni esclusivamente in posizione orizzontale, avvolto nella ormai logora veste da camera, disteso ora sul letto ora sul divano, assistito ora amorevolmente ora rabbiosamente dal cencioso servitore Zachàr, senza il quale non sarebbe più nemmeno in condizione di riuscire a infilarsi le calze e le scarpe. Senza parlare del resto: Oblòmov non svolge alcuna attività né fisica (ad eccezione dell’ingurgitare i troppo copiosi pasti) né mentale. Infatti, non amministra la sua proprietà, che va in rovina nelle mani del disonesto stàrosta, il quale a intervalli regolari minaccia di non fornirgli più nemmeno l’indispensabile rendita ricavata dalla vendita del grano; non lavora al grande progetto di ammodernamento e di ristrutturazione della lontana tenuta (una strada, un ponte, un tetto nuovo…), che pure ne avrebbe un gran bisogno; non frequenta nessun vicino né svolge una benché minima vita di società; non ha una fidanzata, forse perché, grasso e mal ridotto com’è, avrebbe vergogna di mostrarsi a distanza ravvicinata. E nel rinviare continuamente la “vita vera” a un futuro imprecisato, come se vivere non dipendesse da lui, non fa che chiedersi:
“Quando, dunque, si potrà iniziare a vivere?”
È questa la domanda essenziale, costitutiva, della sua sindrome, che al momento non ha altro nome (anche se oggi potremmo dargliene vari) se non quello, coniato dall’efficientissimo e positivo amico Stolz, di oblòmovismo: i desideri sono tutti morti tranne quello per il cibo, la vita è un’inutile fatica senza scopo e l’otium più devastante vince sul benefico negotium: che senso ha il fare quando non si ha la forza nemmeno di gridare: Zachàr!!
L’amore, però, potrebbe avere una buona forza detonatrice, e far saltar tutto: e tuttavia, benché Oblòmov si innamori, ricambiato, della bella, intelligente ma critica Ol’ga, egli non può fare a
meno di pensare che in fondo questo per lei non sia altro che un errore. E poi, troppo esigente, Ol’ga, nel pretendere da lui il cambiamento, l’attività, l’abbandono delle antiche e deleterie abitudini per una vita activae in qualche modo produttiva. Stolz (nome non a caso coniato sull’aggettivo tedesco che significa ‘orgoglioso’) resta un modello inarrivabile. L’amore – o piuttosto qualcosa che somiglia a una dipendenza/simbiosi, e a un accomodamento all’apparenza perfetto – arriva invece con la buona, accondiscendente vedova Agafia Matvéievna, che lo accoglie nella sua casa e gli dà un figlio senza chiedergli nulla in cambio; soprattutto, senza chiedergli di cambiare di una virgola il suo stile di vita, che negli anni è rimasto sempre lo stesso: il letto, il divano, il cibo, il sonno, e un progressivo ottundimento di tutte le facoltà fisiche e mentali fin dentro il gorgo letale di una sconfinata apatia, che oggi probabilmente chiameremmo grande depressione. Non servirà a nulla nemmeno che il suo vecchio amico Andréi Stolz, ormai marito di Ol’ga, vada a cercarlo e cerchi ancora una volta disperatamente quanto inutilmente di smuoverlo dal suo letargico confino.
Ma di questa apatia si muore: a un primo “colpo” – così come lo definisce mestamente lo stesso Oblòmov – che gli paralizza una gamba, ne segue un secondo, questa volta mortale. Eppure, lo ricorda Andréi “… non era più stupido degli altri, aveva un’anima pura e limpida come il cristallo, era nobile, affettuoso e… è morto!”–ed è con queste parole, e con l’implacabile diagnosi di “oblomovismo” che consegna la storia al suo amico scrittore, anch’egli “un uomo apatico, con due occhi pensierosi e un po’ sonnolenti” che, nella finale chiusura del cerchio e del romanzo, non può non ricordarci qualcuno.
Recensione di Laura Bocci